
|
|

|
|||

|
|||||
|
Dalla COLOMBIA alla TERRA DEL FUOCO
Tre giorni perduti prima di poter iniziare le pratiche per ritirare il camper dal porto ma nello stesso tempo una bella opportunità per conoscere quei gioielli di architettura coloniale che sono i quartieri della città vecchia. Cartagena ha dietro di se una lunga storia di assedi e saccheggi, però è riuscita a conservare immutato il suo fascino. Passeggiamo la sera alla fioca luce dei lampioni nelle stradette dall'acciottolato consunto dal passare delle carrozze, o lungo le fortificazioni con le batterie di antichi cannoni e ci si sente come trasportati in un epoca in cui in rada attraccavano i galeoni carichi d'oro ed era teatro di epiche battaglie con i pirati. La città nuova è elegante e si stende lungo la spiaggia di Bocagrande, le strade brulicano di gente di ogni tonalità di colore, prevale il nero mentre è quasi assente il bianco.
Le precauzioni che avevamo preso a Panama di portare con noi tutto il contenuto si sono rivelate giuste, infatti ci accorgiamo che il camper è stato rovistato in ogni angolo, impronte di mani e di grasso su tutte le maniglie e alcuni oggetti di poco valore che avevamo lasciato sono regolarmente spariti. La Colombia non gode certo fama di essere un paese sicuro, in Centro America avevamo sentito parlare di quello che capita ai viaggiatori: rapine a mano armata anche in pieno giorno, orologi strappati dal polso, dita mozzate per impadronirsi degli anelli, ogni genere di scippo e un primato a livello mondiale in fatto di assassinii e violenze. La mattina leggendo i giornali abbiamo conferma che purtroppo tutto corrisponde a verità, con l'aggiunta della guerriglia che ora controlla intere regioni. Comunque siamo felicissimi di avere nuovamente il camper con noi e l'impagabile sensazione di essere autonomi ed indipendenti da tutto. Rinnoviamo le nostre provviste al primo supermercato e euforici iniziamo il nostro viaggio attraverso il Sud America.
Il primo pernottamento è a Planeta Rica, una cittadina piuttosto squallida e ci sistemiamo davanti a un alberghetto. La gente viene a salutarci e ci mettiamo a chiacchiera fino a tardi perché con il caldo e l'umido non abbiamo nessuna voglia di infilarci nel camper che ancora trattiene il calore della giornata. Dopo 300 chilometri di pianura la strada inizia a risalire la valle del Cauca, le piantagioni di canna da zucchero lasciano il posto a quelle di caffè. Intere colline sono ricoperte da questi arbusti dal lucente fogliame verde scuro. Haciendas, con l'immancabile piscina, si alternano a modesti villaggi. I posti di blocco sono frequenti e ogni volta immancabilmente veniamo fermati, pensiamo per pura curiosità. "y de donde vienes?" chiedono i poliziotti, per lo più giovani allegri che poco hanno in comune con l'immagine del poliziotto sudamericano grintoso e arrogante, scambiamo quattro parole e spesso, senza neppure chiederci i documenti, ci fanno proseguire. Ovunque ci fermiamo incontriamo gente cordiale e scherzosa. A Ibague il signor Benjamin Botero, cugino del famoso artista, ci invita a parcheggiare nel suo hotel e ci colma di mille cortesie. Di fronte a tante manifestazioni di amicizia ogni nostro timore e prevenzione svanisce e incominciamo a sentirci perfettamente a nostro agio. Dopo Medellin, città dinamica e piena di grattacieli, traversiamo a 3800 metri la cordigliera scendendo poi nella valle del Rio Magdalena che risaliamo fino a San Agustin, dove si trova l'unico posto di interesse archeologico del paese. Qui ha vissuto, mille anni prima dell'arrivo degli spagnoli, una popolazione proveniente dall'Amazzonia che ci ha lasciato ricche vestigia di una misteriosa cultura megalitica con steli di divinità ignote e terrificanti. S. Agustin è in piena zona di guerriglia, la caserma della polizia è circondata da muri di sacchi di sabbia e pietre, le finestre sono protette da reti anti-granata. Le strade sono costantemente pattugliate da soldati pesantemente armati. Ci dicono di non farci impressionare da queste dimostrazioni di forza, in realtà l'esercito non si azzarda ad uscire dall'abitato e la guerriglia spadroneggia appena pochi chilometri fuori dal paese, dove conduce una lotta feroce contro i paramilitares, le milizie private dei ricchi latifondisti e delle grandi società che costituiscono il vero obiettivo. Per proseguire da San Agustin in direzione di Popajan dobbiamo scegliere se rifare a ritroso la strada fino a Pereira e ripassare nella Valle del Cauca o superare la Cordilliera del Buej su una strada a sterro a oltre 4200 metri di altitudine: 720 chilometri la prima soluzione, soli 107 la seconda. Alla stazione degli autobus ci informiamo con gli autisti che percorrono la via diretta ogni giorno e chiediamo se con il nostro mezzo, che ha un'altezza dal suolo insufficiente per le strade di questi paesi, c'è la possibilità di passare. Guardano con attenzione sotto il camper, ci pensano un po' - "Ce la potete fare, se non piove...."; - " e i guerriglieri?" - domandiamo - "No ay peligro". In fondo è quello che vogliamo sentirci dire. La strada in realtà è una mulattiera non più larga di tre metri tagliata nel fianco della montagna sempre sul filo del precipizio, nel fondo si vede il filo sottile del Rio Magdalena. Ogni tanto ci sono delle piazzole per permettere lo scambio con i rari veicoli che incrociamo, decrepiti autocarri stracarichi di gente e mercanzia. La guida non permette la minima distrazione, occhi sempre fissi alla strada e mani aggrappate al volante cercando di non guardare l'abisso verso il quale non c'è la minima protezione. Decine di croci con un nome e una data a ricordo di tanti voli nel vuoto. Sempre con la seconda ingranata arriviamo fino a 3000 metri, poi vediamo addensarsi densi nuvoloni neri e sentiamo il brontolio del tuono. Poco dopo inizia a piovere con autentica furia. Una cortina d'acqua sferza il parabrezza e dobbiamo smontare la protezione di plexigas perché la visibilità è ridotta a zero. Avanziamo molto lentamente. La strada si trasforma in breve nel letto di un torrente, le buche diventano più profonde, spesso dobbiamo scendere e riempirle con pietre per poter uscire dal fango e proseguire. Raggiungiamo intorno ai 4000 metri il paramo, la steppa andina. Poco dopo inizia la lunga discesa in una fiumana di fango scivoloso come una saponetta, la guida richiede una concentrazione ancora maggiore. Superato l'ultimo passo scorgiamo nella valle i tetti rossi di Coconoco, ce l'abbiamo fatta! Ci fermiamo esausti nel parcheggio di un albergo di fronte a una sorgente termale. Il direttore ci accoglie cordialmente e quando sente che veniamo da San Agustin ci chiede -"Vi hanno fermato?"-. No, alla guerriglia proprio non ci avevamo pensato, l'unica nostra preoccupazione è stata quella di non finire in fondo a un burrone! In una giornata di guida abbiamo percorso 90 chilometri.
Cambiamo emisfero e abbiamo la sensazione che la parte più impegnativa del viaggio sia ormai dietro di noi. Oltre la cordigliera c'è la cittadina di Santo Domingo de los Colorados di cui avevamo molto letto in resoconti di viaggio, dove vivono appunto gli indios Colorados che indossano, anche gli uomini, una gonnellina a strisce, si dipingono il corpo e si coprono la testa con una specie di calotta di fango rosso.
In fondo è stato meglio così perché sicuramente avremmo assistito a una pagliacciata turistica come purtroppo ci è capitato in altre occasioni; i Colorados continueranno a restare sulle pagine patinate dei cataloghi dei tour-operators che li gabelleranno come escursioni di interesse etnografico. Sotto una pioggia torrenziale lasciamo le montagne e ci avviciniamo alla costa del Pacifico; sempre più drammatiche appaiono le distruzioni provocate dalle alluvioni del Nino del gennaio scorso. Montagne franate, strade e ponti distrutti, villaggi spazzati via dalla furia delle acque. La situazione economica del paese, da sempre precaria, ha subito un gravissimo colpo per la distruzione dei raccolti e si ha l'impressione che manchi di tutto. Per noi è il paese del "No hay", perfino gli uffici postali non hanno francobolli. Ad Atacames, dove c'è una missione retta da religiosi di Prato, le autorità distribuiscono viveri donati dal governo italiano. Su strade tutte buche e cumuli di fango traversiamo la zona bananera, migliaia di ettari di monocoltura dominata dalle grandi compagnie nordamericane, marche che noi conosciamo dai banchi dei nostri supermercati "Del Monte", "Chichita", "Dole". Non è comunque facile visitare una piantagione, si è accolti con molta diffidenza e se ne capisce il motivo quando si vede il duro lavoro degli operai e soprattutto l'enorme quantità di prodotti chimici che viene impiegata. Aerei a volo radente spruzzano pesticidi e anticrittogamici che vanno poi a finire nelle acque dei fiumi e nei polmoni dei bananeros.
La prima località che incontriamo è Tumbes, la tipica città-guarnigione. Nei prossimi due giorni sarà festa nazionale "Fiestas Patrias" e in città già stanno preparando palchi per le sfilate e le bande stanno provando un repertorio che comprende marce militari e passe-doubles. La situazione di frontiera con l'Ecuador è in questi ultimi tempi particolarmente tesa a causa di una disputa su un pezzo di Amazzonia che i due paesi si contendono dal secolo scorso e che di tanto in tanto, spesso al solo scopo di scaricare tensioni interne, viene riacutizzata La Panamericana traversa ora il deserto costiero, migliaia di chilometri di sabbia fino al Cile centrale, una delle zone più aride della terra; alte dune, quasi sahariane, si stendono fino alla catena delle Ande. In questa regione non piove praticamente mai, però l'inverno passato il Nino ha portato anche qui piogge tanto abbondanti che in una parte del deserto di Sechura si è creata una grande laguna interna. L'asfalto è passabile e procediamo spediti.
Lima non è certo una capitale che invita a trattenersi, le costruzioni in stile coloniale sono state distrutte da terremoti passati e da speculazioni recenti, oggi appena dietro la "Plaza de Armas", il centro storico della città, esistono anonimi blocchi di cemento grigio. La città, che ha ufficialmente otto milioni di abitanti, è circondata da miseri agglomerati di casupole color terra, costruite con mattoni cotti al sole e paglia senza fogne nè servizi, che qui con un elegante eufemismo chiamano "Pueblos jovenes". Alcune di queste casette sono dipinte di blu, altre di rosa senza però cambiare di molto il quadro di grande squallore. Il tempo si mantiene plumbeo, con nuvole basse che minacciano costantemente una pioggia che non verrà, è la garua che avvolge la costa del pacifico nei mesi invernali e che fa apparire la città ancora più grigia di quello che non sia. Lasciamo Lima senza rimpianti e proseguiamo verso la penisola di Paracas e Nazca che è nota per le misteriose linee tracciate nel deserto e sulle quali sono state azzardate le più strampalate teorie. Volando con un piccolo aereo effettivamente si riconoscono chiaramente alcuni segni che rappresentano una balena, una scimmia, il colibri e ancora più nitide sono le figure geometriche.
Ormai stiamo entrando nella zona più turistica del paese e sempre più frequentemente incontriamo gruppi di turisti italiani. Arequipa è la città più bella del Perù, situata a 2200 metri e dominata dal perfetto cono del El Misti, è il posto ideale per una sosta prolungata e come base per viaggi verso l'interno. Ci fermiamo nel parcheggio dell'Holiday Inn di cui è proprietario Antonio Vellutino, di origini piemontesi, che con sua moglie Ani ci accoglie con una grande generosità e ci danno l'impressione di essere come a casa nostra. Organizziamo da qui un'escursione al canyon del Colca, che ha una profondità doppia di quello del Colorado e dove vivono ancora antiche popolazioni che coltivano terrazzamenti che risalgono a epoche preincaiche. Per la prima volta scorgiamo un condor che si libra a breve distanza da noi, le sue dimensioni non sono ben percettibili fin quando non batte un colpo di ali che hanno quasi quattro metri di apertura: fantastico! La strada che sale sulle Ande è uno sterrato dei peggiori e non vogliamo ripetere l'esperienza della Colombia, quindi decidiamo di prendere da Arequipa l'aereo fino a Cusco e poi proseguire in treno e bus.
Ci tratteniamo sull'altopiano una decina di giorni, poi sempre in treno traversando vallate aride dove cresce solo erba giallastra e arriviamo a Puno, sul lago Titicaca, a 3800 metri. La notte è molto freddo. Il Titicacaca è il lago più grande del Sudamerica ma è diventato famoso nel mondo per gli indios Uros che vivono lungo le sue rive su piccole isole galleggianti di canne di "totora". Puno è situato in un ramo morto del lago simile a una palude che è coperto da uno strato di alghe color verde chiaro originate dal forte inquinamento delle acque. Sappiamo che gli Uros costruiscono le loro capanne sulle isole, vanno a pesca sulle tipiche imbarcazioni anche queste fatte di "totora" e addirittura mangiano le parti più tenere di questa pianta. La realtà è assai diversa, gli Uros praticamente non esistono più e quelli che vedono e fotografano le schiere di turistici che vengono ogni giorno traghettati alle isole sono degli indios dei dintorni che si guadagnano da vivere vendendo maglioni di alpaca e altri souvenirs; della vita reale della gente non si vede poco o niente. Puno vive e prospera su un falso creato e sfruttato dall'industria turistica. Nei nostri spostamenti gente incontriamo turisti di varie nazionalità e capita di fare alcune tappe in piacevole compagnia, però sentiamo sempre la mancanza del nostro camper che, se è vero che ci isola un po' dal mondo esterno, ci offre però tante di quelle comodità e piccole abitudini domestiche che permettono una prolungata assenza da casa, che non sarebbe possibile viaggiando con mezzi pubblici, ristorante e albergo.
Una ventina di chilometri oltre il confine e giungiamo ad Arica, siamo ai Tropici, ma il clima è fresco e non c'è nulla di particolarmente esotico. Da qui alla nostra meta, la Terra del Fuoco, ci separano quasi cinquemila chilometri, la stessa distanza che c'è fra Capo Nord e Napoli. Il paesaggio fino a Santiago è dei più monotoni. Il deserto cileno è coperto da una crosta di nitrati, la cui estrazione procurò enormi profitti alle compagnie minerario fino a quando, negli anni venti in Germania fu inventato il sistema di produrli sinteticamente. Era la fine del monopolio cileno: migliaia di lavoratori lasciarono le oficinas, paesi ed impianti furono invasi dalla sabbia. Nella zona di Atacama incontriamo molti i questi villaggi abbandonati. Uno di questi è Humberstone che raggiungiamo a piedi.
Lo spettacolo più bello il deserto lo offre di notte, quando ci accampiamo. Finita la cena, dopo aver ascoltato il notiziario dall'Italia sulla radio ad onde corte, mettiamo fuori le seggioline e con un bicchiere di buon vino cileno in mano restiamo a guardare le stelle sconosciute, in un cielo luminoso come mai avevamo visto prima. Proseguiamo per Antofagasta, il traffico è quasi inesistente, si trova un distributore d carburante mediamente ogni trecento chilometri. A Calama deviamo nell'interno e ci troviamo a Chuquicamata, dove c'è la più grande miniera di rame a cielo aperto del mondo: qui lavorano oltre novemila persone e visitiamo gli impianti fin sull'orlo della voragine profonda 750 metri e larga quattro chilometri, una strada si avvita verso il fondo simile ad un immenso girone infernale. Da quando siamo in Cile abbiamo finalmente l'impressione di essere arrivati in un paese sicuro. Possiamo campeggiare praticamente ovunque, senza dover dormire con un occhio solo e sobbalzare sul letto al minimo rumore.
Siamo a Santiago e, come in tutte le grandi città, si ripropone il problema di dove pernottare. Sulla cartina è indicato un riquadro verde con l'indicazione estadio italiano e pensiamo che si tratti di un impianto sportivo. In realtà non è uno stadio ma un vero e proprio centro sportivo dove veniamo accolti molto cordialmente. Il club ha ottomila soci, tutti di origine italiana, che occupano posizioni di rilievo nella società cilena. Dopo Santiago inizia la zona temperata, che si estende per mille chilometri fino a Puerto Montt con frutteti, campi e vigne a perdita d'occhio. Poi il paese inizia a perdere la struttura continentale e si disgrega in una miriade di isole e fiordi, in un paesaggio molto simile a quello dell'Alaska. L'unica possibilità per proseguire lungo la costa cilena è quella di prendere il traghetto settimanale che in quattro giorni raggiunge Puerto Natales. La nave lascia il porto con l'alta marea a sirene spiegate e per ore ci segue la vista della sagoma imponente del vulcano Osorno coperto di neve. La navigazione è piacevole, l'oceano nei fiordi è liscio come l'olio. Il secondo giorno inizia a cadere una pioggia gelida e il vento soffia sempre più forte: ci stiamo avvicinando alla Patagonia. Nella notte traversiamo il Golfo de Penas, un tratto di mare aperto e costantemente in tempesta. Dopo dodici ore di inferno finalmente rientriamo in un fiordo e a bordo la vita riprende anche se si vedono molte facce dal colorito livido, una ragazza tedesca si è rotta un braccio cadendo e numerose pecore stivate in un camion sono morte schiacciate o di paura. Il quarto giorno di navigazione arriviamo a Porto Natales: il sole finalmente riappare mettendo in risalto i colori vivaci delle case di legno. Puerto Natales è il punto di partenza per le escursioni verso il Parco del Paine: per giorni abbiamo sotto le ruote strade non asfaltate, senza neppure incontrare un solo veicolo; nel retrovisore non vediamo altro che la nuvola di polverone che ci segue. Dopo Punta Arenas la strada corre lungo lo Stretto di Magellano e la solitudine è assoluta. I rari punti di riferimento sono le estancias che spesso comprendono varie costruzioni, dal capannone per la tosa delle pecore, alle officine, alle case del personale.
Costeggiando lo stretto si vedono sulle spiagge i relitti dei velieri ormai corrosi dalla salsedine che cercavano di doppiare Capo Horn. Alla prima strettoia dello stretto c'è il traghetto per l'isola della Terra del Fuoco: ci troviamo di fronte a un barcone in ferro, una specie di mezzo da sbarco militare che abbassa la rampa direttamente sulla spiaggia ghiaiosa: non esiste un molo e si sale con la marea.
Mancano ancora 600 chilometri su una strada in terra battuta ondulata come un asse da bucato: si può viaggiare solo a quindici chilometri l'ora, salendo e scendendo delicatamente su ogni ondulazione, oppure a ottanta volando sulle creste con pochissima aderenza al suolo; alle velocità intermedie il camper vibra fino alla nausea.
Il vento diventa sempre più forte per due giorni guidiamo in un turbine di sabbia e pietrisco: alla fine il parabrezza di plastica è completamente picchiettato e la vernice del cofano abrasa, con il vetroresina a nudo. Raggiunto il Passo Garibaldi inizia la discesa verso Ushuaia, la città più australe del mondo. Ci fermiamo una notte e proseguiamo fino alla Bahia Lapataia, il punto più meridionale che si possa raggiungere con un veicolo, oltre ci sono il Canale di Beagle e Capo Horn. Siamo veramente alla fine del mondo, oltre queste terre di gelo e di vento si apre il nulla. Ci fermiamo a raccogliere le emozioni e con il pensiero torniamo indietro di un anno e mezzo, quando ci trovavamo a Circle in Alaska. Diamo un'occhiata al contachilometri: abbiamo percorso 46.210 chilometri.
"La maggior parte di noi porta dentro di sé per tutta la vita un sogno, per noi questo sogno è stato quello di poter fare, un giorno, un viaggio in camper intorno al mondo. Un viaggio che si è alimentato per decenni di letture, proiezioni, incontri con persone che, con i loro racconti, ci rendevano partecipi delle loro esperienze in paesi lontani.
Viaggio effettuato nel 1998-1999 da Cesare Pastore, www.campervagamondo.it. Potete trovare ulteriori informazioni sulle località toccate da questo itinerario nella sezione METE. |
| |||||||||||||||||||||||||





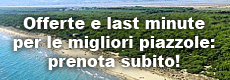














 Arriviamo a Cartagena sotto un sole cocente e la città è deserta, siamo in pieno clima dei mondiali di calcio e si sta giocando Colombia - Inghilterra. Dalle finestre aperte e dai bar si odono gli ululati dei commentatori televisivi. Il tassista che ci porta al centro tiene la radio a tutto volume, poco prima di arrivare al nostro albergo la Colombia incassa un secondo gol: "mala suerte!" Arrivando di venerdì pomeriggio, poco prima dell'inizio di un lungo fine settimana, abbiamo poca fortuna anche noi, ci attendono infatti tre giorni festivi perché il lunedì successivo è San Pietro e Paolo.
Arriviamo a Cartagena sotto un sole cocente e la città è deserta, siamo in pieno clima dei mondiali di calcio e si sta giocando Colombia - Inghilterra. Dalle finestre aperte e dai bar si odono gli ululati dei commentatori televisivi. Il tassista che ci porta al centro tiene la radio a tutto volume, poco prima di arrivare al nostro albergo la Colombia incassa un secondo gol: "mala suerte!" Arrivando di venerdì pomeriggio, poco prima dell'inizio di un lungo fine settimana, abbiamo poca fortuna anche noi, ci attendono infatti tre giorni festivi perché il lunedì successivo è San Pietro e Paolo.
 Con il primo giorno lavorativo siamo puntuali al porto ma ci rendiamo conto che le formalità sono più complicate del previsto e decidiamo quindi di ingaggiare un agente che ci guidi nella babele della burocrazia colombiana. Percorriamo innumerevoli volte in taxi il tragitto fra il terminal e il centro perché i vari uffici sono sparsi per tutta la città. I timbri, le autorizzazioni e i formulari si sprecano ma a fine giornata entriamo in possesso del camper e la notte stessa possiamo dormirci.
Con il primo giorno lavorativo siamo puntuali al porto ma ci rendiamo conto che le formalità sono più complicate del previsto e decidiamo quindi di ingaggiare un agente che ci guidi nella babele della burocrazia colombiana. Percorriamo innumerevoli volte in taxi il tragitto fra il terminal e il centro perché i vari uffici sono sparsi per tutta la città. I timbri, le autorizzazioni e i formulari si sprecano ma a fine giornata entriamo in possesso del camper e la notte stessa possiamo dormirci.
 In un caldo torrido traversiamo la larga pianura costiera dove i pascoli si alternano a piantagioni tropicali e facciamo subito conoscenza con lo spericolato stile di guida dei colombiani che sembra non conoscano le più elementari regole del traffico e della prudenza; per la prima volta non ci sentiamo tranquilli alla guida.
In un caldo torrido traversiamo la larga pianura costiera dove i pascoli si alternano a piantagioni tropicali e facciamo subito conoscenza con lo spericolato stile di guida dei colombiani che sembra non conoscano le più elementari regole del traffico e della prudenza; per la prima volta non ci sentiamo tranquilli alla guida.
 Ormai siamo al confine con l'Ecuador e abbiamo trascorso un mese in Colombia senza avere il minimo problema, al contrario abbiamo avuto tante dimostrazione di amicizia. Con l'Ecuador cambia il paesaggio e la gente. Alle grandi piantagioni di caffè si sostituiscono piccoli appezzamenti coltivati a grano, mais e verdure, campicelli ben curati sui fianchi delle montagne con casette sparse ovunque. La popolazione è prevalentemente india, riappaiono i coloriti mercati che non avevamo più visto da quando abbiamo lasciato il Guatemala. Il paesaggio è ridente costellato dalle vette dei vulcani incappucciati di neve. Avevamo sempre pensato che l'equatore fosse, come ci è stato insegnato a scuola, una linea immaginaria che circonda la terra. A soli 17 chilometri a nord di Quito invece l'equatore si può vedere e toccare: è un grande globo di metallo con una linea gialla dipinta sul terreno che parte da una colonna, traversa un piazzale asfaltato e si perde non sappiamo dove. Siamo alla "Mitad del Mundo", foto di rito con un piede nell'emisfero nord, l'altro in quello sud e il camper sullo sfondo.
Ormai siamo al confine con l'Ecuador e abbiamo trascorso un mese in Colombia senza avere il minimo problema, al contrario abbiamo avuto tante dimostrazione di amicizia. Con l'Ecuador cambia il paesaggio e la gente. Alle grandi piantagioni di caffè si sostituiscono piccoli appezzamenti coltivati a grano, mais e verdure, campicelli ben curati sui fianchi delle montagne con casette sparse ovunque. La popolazione è prevalentemente india, riappaiono i coloriti mercati che non avevamo più visto da quando abbiamo lasciato il Guatemala. Il paesaggio è ridente costellato dalle vette dei vulcani incappucciati di neve. Avevamo sempre pensato che l'equatore fosse, come ci è stato insegnato a scuola, una linea immaginaria che circonda la terra. A soli 17 chilometri a nord di Quito invece l'equatore si può vedere e toccare: è un grande globo di metallo con una linea gialla dipinta sul terreno che parte da una colonna, traversa un piazzale asfaltato e si perde non sappiamo dove. Siamo alla "Mitad del Mundo", foto di rito con un piede nell'emisfero nord, l'altro in quello sud e il camper sullo sfondo.  Per arrivare a Santo Domingo non si devono traversare impervi sentieri nella foresta ma ci si arriva su una comoda strada asfaltata, gli indios portano jeans e magliette; restiamo alquanto delusi. Ci viene detto che se vogliamo vedere però i "veri" Colorados dobbiamo prendere una stradina che si inoltra nel bosco per qualche decina di chilometri e li esiste una delle loro ultime comunità. Visto che abbiamo fatto tanta strada per arrivare fin qui, vale la pena di fare qualche chilometro in più. Troviamo in effetti la comunità con gruppi di indios dediti alle loro occupazioni, anche loro vestiti all'europea. Una giovane donna ci viene incontro e ci chiede se siamo solo due o se facciamo parte di un gruppo "Solo noi". "Allora per due persone non stiamo neppure a travestirci" e ci gira le spalle tornando nella sua capanna.
Per arrivare a Santo Domingo non si devono traversare impervi sentieri nella foresta ma ci si arriva su una comoda strada asfaltata, gli indios portano jeans e magliette; restiamo alquanto delusi. Ci viene detto che se vogliamo vedere però i "veri" Colorados dobbiamo prendere una stradina che si inoltra nel bosco per qualche decina di chilometri e li esiste una delle loro ultime comunità. Visto che abbiamo fatto tanta strada per arrivare fin qui, vale la pena di fare qualche chilometro in più. Troviamo in effetti la comunità con gruppi di indios dediti alle loro occupazioni, anche loro vestiti all'europea. Una giovane donna ci viene incontro e ci chiede se siamo solo due o se facciamo parte di un gruppo "Solo noi". "Allora per due persone non stiamo neppure a travestirci" e ci gira le spalle tornando nella sua capanna.
 Il passaggio delle frontiere da quando abbiamo lasciato gli Stati Uniti è stata la nostra croce e anche quella con il Perù non fa eccezione, anzi possiamo dire che è stato uno de passaggi più caotici per il fatto che il posto di confine è nel centro dell'abitato di Huaquillas. Bancherelle e venditori volanti occupano la strada in un tumulto incredibile con il risultato che tutto il traffico è bloccato. Metro per metro avanziamo pregando i venditori di spostare i loro carretti e di farci spazio, qualche volta sbraitando perché non danno il minimo segno di reazione; intervengono un paio di poliziotti che con scarsa convinzione cercano di portare un po' di ordine. Dopo due ore buone arriviamo alla sbarra di confine.
Il passaggio delle frontiere da quando abbiamo lasciato gli Stati Uniti è stata la nostra croce e anche quella con il Perù non fa eccezione, anzi possiamo dire che è stato uno de passaggi più caotici per il fatto che il posto di confine è nel centro dell'abitato di Huaquillas. Bancherelle e venditori volanti occupano la strada in un tumulto incredibile con il risultato che tutto il traffico è bloccato. Metro per metro avanziamo pregando i venditori di spostare i loro carretti e di farci spazio, qualche volta sbraitando perché non danno il minimo segno di reazione; intervengono un paio di poliziotti che con scarsa convinzione cercano di portare un po' di ordine. Dopo due ore buone arriviamo alla sbarra di confine.
 Siamo incuriositi da singolari segnalazioni "Non distruggete i cartelli stradali" oppure "Non date fuoco ai pneumatici"; chiediamo spiegazione a un distributore e apprendiamo che l'avvertimento si riferisce ai camionisti che danno fuoco a vecchie gomme per segnalare la presenza di un camion fermo ai bordi della strada per un guasto e che poi vengono lasciati accesi anche quando sono ripartiti.
Siamo incuriositi da singolari segnalazioni "Non distruggete i cartelli stradali" oppure "Non date fuoco ai pneumatici"; chiediamo spiegazione a un distributore e apprendiamo che l'avvertimento si riferisce ai camionisti che danno fuoco a vecchie gomme per segnalare la presenza di un camion fermo ai bordi della strada per un guasto e che poi vengono lasciati accesi anche quando sono ripartiti.
 Poco oltre c'è il "cimitero" di Chaucilla, che non è altro che una vasta pianura secca e arida cosparsa di ossa profanate, teschi, frammenti di tessuti e mummie che sono pervenute fino a noi in maniera integra grazie all'assoluta secchezza del clima.
Poco oltre c'è il "cimitero" di Chaucilla, che non è altro che una vasta pianura secca e arida cosparsa di ossa profanate, teschi, frammenti di tessuti e mummie che sono pervenute fino a noi in maniera integra grazie all'assoluta secchezza del clima.
 Cusco è la capitale archeologica delle Americhe e i suoi muri massicci di pietre squadrate sovrapposte a secco che costituiscono le fondamenta di molte costruzioni coloniali, sono la testimonianza di quella che era la potente capitale dell'Impero degli Incas. Da qui parte il trenino che zigzagando risale la valle dell'Urubamba fino alla stazione di Aqua Calientes da dove si raggiunge Machu Picchu, la splendida città perduta degli Incas, la cui visita varrebbe da sola un viaggio in Perù.
Cusco è la capitale archeologica delle Americhe e i suoi muri massicci di pietre squadrate sovrapposte a secco che costituiscono le fondamenta di molte costruzioni coloniali, sono la testimonianza di quella che era la potente capitale dell'Impero degli Incas. Da qui parte il trenino che zigzagando risale la valle dell'Urubamba fino alla stazione di Aqua Calientes da dove si raggiunge Machu Picchu, la splendida città perduta degli Incas, la cui visita varrebbe da sola un viaggio in Perù.
 Al confine cileno ci accolgono i volti europei dei carabineros. Gli uffici sono circondati da aiuole fiorite e ben curate, nessuno ci importuna con richiesta di propina, tutti sono gentili e disponibili. E' proprio vero quello che ci era stato detto: in Cile comincia un altro Sud America.
Al confine cileno ci accolgono i volti europei dei carabineros. Gli uffici sono circondati da aiuole fiorite e ben curate, nessuno ci importuna con richiesta di propina, tutti sono gentili e disponibili. E' proprio vero quello che ci era stato detto: in Cile comincia un altro Sud America.
 Il silenzio è assoluto, si sentono solo il frusciare del vento e il cigolio delle lamiere rugginose dei tetti. Le case dei dirigenti inglesi sono quasi intatte: le porte sono spalancate, dei vetri alle finestre restano solo poche schegge attaccate agli infissi, dai muri delle stanze vuote penzolano brandelli di carta da parati ormai stinta. Oltre la chiesetta si estende il cimitero, incredibilmente grande rispetto alle dimensioni del villaggio. Il clima secco ha preservato tutto, sulle croci di legno e di ferro si leggono ancora le date: molti i giovani di enti anni o poco più, vite brevi consumate dal duro lavoro in uno degli angoli più inospitali della terra. A qualche chilometro ci sono gli impianti della miniera: vagoncini rovesciati, ciminiere diroccate, la sala macchine in un caos di pulegge, caldaie e tubi divelti. Qui è tutto autentico, non si paga biglietto di ingresso e non ci sono visitor center come nelle città fantasma del West americano, ricostruite ad uso turistico.
Il silenzio è assoluto, si sentono solo il frusciare del vento e il cigolio delle lamiere rugginose dei tetti. Le case dei dirigenti inglesi sono quasi intatte: le porte sono spalancate, dei vetri alle finestre restano solo poche schegge attaccate agli infissi, dai muri delle stanze vuote penzolano brandelli di carta da parati ormai stinta. Oltre la chiesetta si estende il cimitero, incredibilmente grande rispetto alle dimensioni del villaggio. Il clima secco ha preservato tutto, sulle croci di legno e di ferro si leggono ancora le date: molti i giovani di enti anni o poco più, vite brevi consumate dal duro lavoro in uno degli angoli più inospitali della terra. A qualche chilometro ci sono gli impianti della miniera: vagoncini rovesciati, ciminiere diroccate, la sala macchine in un caos di pulegge, caldaie e tubi divelti. Qui è tutto autentico, non si paga biglietto di ingresso e non ci sono visitor center come nelle città fantasma del West americano, ricostruite ad uso turistico.

 Ci fermiamo all'estancia San Gregorio, fondata nel 1876, ma apparentemente abbandonata: a giudicare dal complesso doveva essere stata una delle più grandi della zona. Ci accoglie Pedro Sanchez, il capataz, minuto, aria vispa, giaccone imbottito, stivali e speroni, il tipico pecoraio della steppa cilena. Mentre ci invita a bere un mate nella cucina disadorna, ci racconta la storia della San Gregorio che sotto certi aspetti è la storia della colonizzazione, spesso violenta, della Patagonia alla fine del secolo scorso. Nelle sue parole ci sembra di rivivere le storie affascinanti dei libri di Chatwin e Sepulveda.
Ci fermiamo all'estancia San Gregorio, fondata nel 1876, ma apparentemente abbandonata: a giudicare dal complesso doveva essere stata una delle più grandi della zona. Ci accoglie Pedro Sanchez, il capataz, minuto, aria vispa, giaccone imbottito, stivali e speroni, il tipico pecoraio della steppa cilena. Mentre ci invita a bere un mate nella cucina disadorna, ci racconta la storia della San Gregorio che sotto certi aspetti è la storia della colonizzazione, spesso violenta, della Patagonia alla fine del secolo scorso. Nelle sue parole ci sembra di rivivere le storie affascinanti dei libri di Chatwin e Sepulveda.





