
|
|

|
|||

|
|||||
|
SINGAPORE, MALESIA E THAILANDIA 
La nave fa scalo a Fremantle solo per poche ore per caricare il nostro camper e una dozzina di container pieni di balle di lana, poi riparte diretta a Singapore, che raggiungerà dopo una settimana; noi aspettiamo qualche giorno e poi la precediamo in aereo per trovarci al porto al momento dello sbarco del mezzo. Già dal viale che conduce dall’aereoporto in centro, Singapore ci appare come una città giardino: siepi, cespugli e rigogliose fioriture ovunque, le pensiline degli autobus coperte da cascate di buganvillea e, sullo sfondo, gli scintillanti palazzi di vetro. Qui malesi, indiani, cinesi, arabi vivono in buona armonia e sottostanno a leggi severe che vengono fatte rispettare rigorosamente: scopriamo ad esempio che è vietato giocare d’azzardo, gettare mozziconi e chewing gum per terra, mangiare in metropolitana. Il transito delle auto nelle vie del centro è a pagamento e il possesso di un’automobile privata è drasticamente scoraggiato.
Singapore è anche il più grande porto del mondo: ogni tre minuti arriva o parte un piroscafo – nel 2001 sono stati 146.000 – ed ogni giorno vengono movimentati 40.000 container.
Entriamo dal portale numero 4, veniamo fotografati e ci viene rilasciato un pass: è la prima volta che ci è permesso di muoverci liberamente all’interno di un porto: sui moli non si vede anima viva, ma ovunque ci sono telecamere che controllano ogni movimento. Gru gigantesche sollevano e scaricano i container ponendoli, con precisione millimetrica, dal ponte delle navi ai pianali dei camion in attesa. Camminiamo per chilometri lungo i corridoi formati dalle pile di cassoni multicolori e quando arriviamo alla nostra banchina la nave ha già attraccato e il camper è stato sbarcato. Sino alla frontiera malese ci sono solo 20 chilometri, ma è richiesto ugualmente il pagamento della tassa di circolazione e una polizza assicurativa. Il poliziotto all’uscita del porto chiude un occhio, però ci intima di lasciare il paese entro mezz’ora e di non fermarci lungo la via. Lentamente ci infiliamo nel traffico e prendiamo l’autostrada per la Malesia: Incredibile, siamo in Asia! Il confine è al termine di un lungo ponte che le auto possono percorrere solo con il serbatoio pieno per almeno tre quarti: in caso contrario viene comminata una multa di 500 dollari, questo per scoraggiare i pendolari del rifornimento oltre frontiera dove il carburante costa quattro volte meno che a Singapore.
I doganieri che distrattamente registrano il nostro Carnet de Passage senza neppure controllare il camper, sono tutte donne insaccate in palandrane azzurre e con in testa un velo di un azzurro più scuro che copre anche la fronte e le fa somigliare a suore; alcune sono giovani e graziose, con profondi occhi neri. Avevamo quasi dimenticato che questo è un paese musulmano, l’unico di tutto il viaggio, e ciò ci crea una certa inquietudine (anche se i venti della seconda Guerra del Golfo sono ancora lontani). A Johor Bahru, la prima città malese appena passato il confine, siamo sommersi dai colori, dagli odori, dal disordine e dal sudiciume dell’Asia. Dopo il lungo periodo trascorso nella sterile Australia non è facile ambientarsi e, un po’ per lo shock culturale e un po’ per l’insopportabile caldo umido, ci sentiamo spaesati e spossati.
Apprezziamo il concerto di musica classica diretto da un maestro giapponese, ma è interessante soprattutto osservare gli spettatori: quello che salta subito all’occhio è la divisione fra malesi e cinesi. Teo ci spiegherà poi, con molto tatto e sottigliezza, che la maggioranza malese detiene il potere politico di cui fa uso – ma soprattutto abuso – ai danni del trenta per cento della popolazione cinese, che è la più laboriosa ed intraprendente e che costituisce il vero motore dell’economia del paese; in parole povere ci sta dicendo “loro comandano ma noi abbiamo i soldi”.
Preferiamo evitare la moderna autostrada e prendiamo la strada costiera che traversa una fertile regione agricola disseminata di villaggi, i kampong. Dove un tempo c’era la giungla dei nostri ricordi salgariani si estendono ora solo piantagioni di palme nella loro ordinata geometria: è la stagione della raccolta e i pesanti grappoli di frutti gonfi d’olio, di un intenso colore rosso-arancione, sono ammucchiati ai margini della strada in attesa dei camion che li porteranno ai frantoi, gli oil mills, annunciati dalle dense nuvole di fumo nero che si sprigionano dalle ciminiere. Malacca si profila in lontananza con una fila di grattacieli: non può essere! Da un nostro precedente viaggio la ricordavamo come una cittadina piccola e quieta, piena di storia e di atmosfera; fu colonia portoghese, poi olandese, venne quindi occupata dagli inglesi e durante la Seconda Guerra Mondiale dai giapponesi. Di questo passato restano molte vestigia, tra cui il forte portoghese A’Famosa, le rovine della chiesa di San Paolo, il quartiere olandese, tutto dipinto di rosso, il bel lungomare alberato.
Giriamo a vuoto un paio di volte senza trovare un posto adatto per pernottare e alla fine ci fermiamo in un parcheggio vuoto fra due strade di grande traffico. Quella di Malacca resterà nei nostri ricordi come una notte da incubo: appena fa buio un locale all’aperto di Karaoke, che non avevamo notato, inizia a tambureggiare a tutto volume, il caldo è asfissiante e dobbiamo tenere aperte tutte le finestre, il traffico sulle due strade è incessante e rumoroso e si placa solo all’alba per poi ricominciare subito dopo. Stravolti dal sonno e dal caldo visitiamo la città vecchia che, per quel poco che è rimasto, assomiglia a un angolo della Cina tradizionale con le case dalle pareti di stuoia intrecciata, i templi avvolti in nuvole di incenso e colmi di statue di divinità ai cui piedi ardono decine di candele, le botteghe degli artigiani.
La vecchia, sonnacchiosa città di impronta coloniale è scomparsa, interi quartieri sono stati rasi al suolo e al loro posto è sorta una moderna capitale con tutte le incongruenze e i contrasti di un paese emergente in equilibrio fra un retaggio di sottosviluppo e un inarrestabile miracolo economico. Un esempio: per arrivare alla stazione ultramoderna del metro bisogna traversare un spiazzo polveroso pieno di spazzatura e sterpaglie, per raggiungere l’edificio tutto vetro e cristallo di una banca si fanno equilibrismi su precarie passerelle di legno gettate su fogne a cielo aperto, i lussuosi centri direzionali sorgono spesso in mezzo a baraccopoli fatiscenti. Il tranquillo quartiere dei diplomatici, con le sue ville dipinte di bianco, è il posto ideale per parcheggiare.
Lasciamo Kaa Lumpur attraverso un’enorme periferia dove sorgono quartieri satelliti fatti di villette a schiera, tutte identiche, e i capannoni di assemblaggio delle multinazionali dell’elettronica. Le alture delle Cameron Highlands sono la prossima destinazione per sottrarci alla caldo torrido della pianura. La strada sale serpeggiando e attraversa la foresta vergine come in un tunnel verdeggiante fino a aggiungere le montagne, i cui fianchi sono stati terrazzati per la coltivazione del tè. L’aria è tersa, la temperatura gradevole e finalmente la notte possiamo dormire.
Anche qui è arrivato il progresso: ci ricordiamo delle coltivazioni di tè a Ceylon con le colline punteggiate dai vivaci colori dei sari delle raccoglitrici tamil che spiccavano a mano le foglie più tenere, una ad una. Qui invece sui cespugli viene passata una specie di tagliasiepe e l’aspiratore raccoglie di tutto: foglie di ogni dimensione, rametti e anche sporcizia. Intorno agli edifici della direzione e delle officine per la lavorazione del tè, in muratura banca con i tetti di bandone, sorge il villaggio di baracche delle famiglie dei lavoratori. Ci piace fermarci nelle piccole comunità, lontani dal frastuono delle città, e il villaggio di Tanah Rata è proprio l’ideale per rilassarci.
Risaliamo la penisola sempre immersi in una natura splendente, dove le piantagioni di caucciù si alternano a risaie di un verde tenerissimo. Nuvoloni neri ogni tanto ci scaricano addosso diluvi di pioggia di una violenza che si vede solo ai tropici: il monsone autunnale è ormai prossimo. La temperatura di giorno rimane stabile sui 33 gradi e scende di poco solo a notte fonda, l’umidità è di oltre il novanta per cento; vestiti e biancheria non si asciugano mai e siamo costretti a dormire su materassi e cuscini costantemente inzuppati di sudore. Dopo aver lasciato Penang arriviamo al confine con la Thailandia e anche qui c’è un grande cartello che stavolta ammonisce “Non portare l’AIDS a casa”: raffigura una bella fanciulla che offre un fiore a un visitatore ma sotto la manica del mantello si intravede la mano ossuta di uno scheletro. L’avvertimento non è superfluo perché è noto che le località tailandesi lungo il confine prosperano sulla prostituzione, la clientela viene perlopiù dalla Malesia, da dove vengono organizzate addirittura gite in bus “tutto compreso” (spesso anche l’AIDS) per soli uomini.
Qui a sud fra i due paesi non si avverte grande differenza: i villaggi che attraversiamo sono dominati dai minareti e dai tetti verdi delle moschee, gli uomini portano la papalina e le donne sono imbacuccate anche più delle malesi. Passata Krabi la costa, in un susseguirsi di spiagge bianchissime, assume un aspetto turistico. Un lungo ponte conduce all’isola di Phuket, che negli ultimi decenni è stata purtroppo deturpata da una speculazione edilizia indecente. Intere insenature e litorali sono occupati da complessi alberghieri che non permettono il passaggio al mare; le cittadine, tirate su senza criterio, sono invase da bancarelle, discoteche, negozi di souvenir e persino sartorie che confezionano abiti in ventiquattro ore, per le strade passeggiano gruppi di turisti europei e australiani abbrustoliti dal sole tropicale. La gente, ormai abituata a considerare i turisti materia prima da cui ricavare il maggior profitto possibile, è strafottente e spesso, se rifiuti la merce o servizi che offrono, anche aggressiva. Verso nord incontriamo molte altre località della costa che sono state “valorizzate”, che significa che hanno perduto per sempre la loro identità.
La sabbia allora era cosparsa solo di alghe e ossi di seppia e il mare era trasparente, ora ci sono cumuli di spazzatura, sacchetti di plastica, chiazze di catrame e nell’acqua marrone galleggiano festoni sfrangiati di carta igienica. Sul lungomare osserviamo maturi uomini occidentali che sono venuti fin qui a comprarsi la fidanzata e li vedi passeggiare, mano nella mano, con fanciulline locali. L’unica cosa che ritroviamo intatta è il night market, il mercatino notturno, dove andiamo a cenare. Appena fa buio alcune strade del centro vengono chiuse al traffico e in pochissimo tempo sono invase da decine di banchetti, ciascuno con la sua specialità. Sui carboni ardenti vengono arrostiti spiedini di carne, dalle grandi padelle di ferro ricolme di frutti di mare e di verdure si levano nubi di fumo, la frutta tropicale è tagliata ed esposta in forme eleganti, l’aria è impregnata di odori che catturano la gola. Da questi ristorantini ambulanti i turisti dei grandi alberghi si tengono alla larga perché li ritegono, a torto, poco affidabili sotto l’aspetto igienico; invece tutto viene cotto al momento e gli ingredienti sono freschissimi.
Lo visitammo nelle prime ore del mattino, quando i canali erano affollati di barchette ricolme di frutta e verdura appena colta, un vero arcobaleno di colori. Le canoe erano condotte con grande maestria ed eleganza da donne che portavano i tipici cappelli a cono e offrivano la loro mercanzia a chi si avvicinava alle scalinate, oppure la consegnavano ai conducenti dei camion per essere trasportata nelle grandi città. Vorremmo dunque rivivere questo spettacolo e già la sera prima arriviamo nel piccolo villaggio per poter vedere il mercato nel momento della sua maggiore animazione.
Come per incanto i canali si popolano di imbarcazioni sbucate chissà da dove, condotte come allora da donne con i cappelli a cono: ma a bordo non ci sono più frutta e verdura bensì una deprimente paccottiglia di souvenir, false magliette Lacoste, copy watsches offerti dalle venditrici che urlano a squarciagola “cheap, very cheap”. Lungo i canali più grandi arrivano, con un frastuono assordante di scappamenti, flottiglie di battelli carichi di altre orde di turisti. L’assedio è completo e il povero mercato galleggiante dei nostri ricordi in pochi minuti si trasforma in un vociante e volgare bazar. Uno degli spettacoli più pittoreschi della Thailandia viene così mercificato ad uso e consumo dei turisti che si accontentano di una grottesca messinscena. Questa esperienza ci conferma che non bisognerebbe mai tornare nei luoghi di cui si conserva un bel ricordo: il passato non si replica e i posti cambiano, molto spesso in peggio, e naturalmente cambiamo anche noi con il nostro modo di vedere e sentire le cose.
E’ con questo spirito e con un senso di inquietudine che riprendiamo la strada per la nostra prossima tappa, Bangkok.
"La maggior parte di noi porta dentro di sé per tutta la vita un sogno, per noi questo sogno è stato quello di poter fare, un giorno, un viaggio in camper intorno al mondo. Un viaggio che si è alimentato per decenni di letture, proiezioni, incontri con persone che, con i loro racconti, ci rendevano partecipi delle loro esperienze in paesi lontani.
Viaggio effettuato nel 2002 da Cesare Pastore, www.campervagamondo.it. |
| |||||||||||||||||||||||||





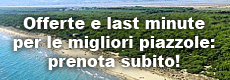















 La Malesia si presenta con un grande cartello che mostra un nodo scorsoio e la scritta “pena di morte per chi trasporta droga!”, be beware, sei avvisato. Per chi viene trovato con più di 15 grammi di eroina scatta automatica la condanna alla pena capitale; non è un mistero che nel lucroso traffico degli stupefacenti siano coinvolti uomini d’affari rispettabilissimi e militari, ma con la corda al collo finiscono solo i pesci piccoli, spacciatori e corrieri di poco conto.
La Malesia si presenta con un grande cartello che mostra un nodo scorsoio e la scritta “pena di morte per chi trasporta droga!”, be beware, sei avvisato. Per chi viene trovato con più di 15 grammi di eroina scatta automatica la condanna alla pena capitale; non è un mistero che nel lucroso traffico degli stupefacenti siano coinvolti uomini d’affari rispettabilissimi e militari, ma con la corda al collo finiscono solo i pesci piccoli, spacciatori e corrieri di poco conto.
 Ai margini della città riusciamo a trovare un posto tranquillo, fuori dal trambusto, in una stradina con eleganti villette. Abbiamo appena parcheggiato quando arriva un signore cinese che si presenta compitissimo con il su biglietto da visita: si chiama Teo Mong Nguan e ci dice che è onoratissimo della nostra scelta di fermarci davanti alla sua casa. Ci viene da ridere ripensando al nostro arrivo negli Stati Uniti quando ad Annapolis, nel Maryland, in una situazione simile i residenti chiamarono la polizia per farci sloggiare pensando che fossimo dei malfattori che stavano spiando la loro casa… Il signor Teo ci chiede se abbiamo bisogno di qualcosa e se siamo interessati ad andare a un concerto con lui e la sua famiglia: -“stasera alle 20, per favore in abbigliamento formale”-. E’ la prima volta in tutto il viaggio che ci si presenta l’occasione di vestirci così: io sudo in giacca e cravatta che da quando ho lasciato la banca non indosso più se non alle cerimonie, Lisa si è portata dietro un elegante tailleur di seta e così vestiti, o travestiti, non sfiguriamo affatto tra il pubblico del teatro.
Ai margini della città riusciamo a trovare un posto tranquillo, fuori dal trambusto, in una stradina con eleganti villette. Abbiamo appena parcheggiato quando arriva un signore cinese che si presenta compitissimo con il su biglietto da visita: si chiama Teo Mong Nguan e ci dice che è onoratissimo della nostra scelta di fermarci davanti alla sua casa. Ci viene da ridere ripensando al nostro arrivo negli Stati Uniti quando ad Annapolis, nel Maryland, in una situazione simile i residenti chiamarono la polizia per farci sloggiare pensando che fossimo dei malfattori che stavano spiando la loro casa… Il signor Teo ci chiede se abbiamo bisogno di qualcosa e se siamo interessati ad andare a un concerto con lui e la sua famiglia: -“stasera alle 20, per favore in abbigliamento formale”-. E’ la prima volta in tutto il viaggio che ci si presenta l’occasione di vestirci così: io sudo in giacca e cravatta che da quando ho lasciato la banca non indosso più se non alle cerimonie, Lisa si è portata dietro un elegante tailleur di seta e così vestiti, o travestiti, non sfiguriamo affatto tra il pubblico del teatro.
 Dopo qualche giorno decidiamo di iniziare la risalita verso il nord del paese.
Dopo qualche giorno decidiamo di iniziare la risalita verso il nord del paese.
 Speravamo di sostare proprio nei giardini fra la città vecchia e il mare: tutto sparito, la costa si è allontanata di almeno un paio di chilometri, invece dell’acqua ora c’è la terraferma e lo sguardo si ferma sulle torri di uno shopping center e sui condomini alti venti piani.
Speravamo di sostare proprio nei giardini fra la città vecchia e il mare: tutto sparito, la costa si è allontanata di almeno un paio di chilometri, invece dell’acqua ora c’è la terraferma e lo sguardo si ferma sulle torri di uno shopping center e sui condomini alti venti piani.
 Anche Kuala Lumpur è completamente cambiata: nuove strade, i soliti altissimi palazzi di cristallo, una metropolitana e una monorotaia sopraelevata dove un computer sostituisce il manovratore, tutto dominato dai 485 metri del grattacielo pi alto del mondo, le torri gemelle Petronas.
Anche Kuala Lumpur è completamente cambiata: nuove strade, i soliti altissimi palazzi di cristallo, una metropolitana e una monorotaia sopraelevata dove un computer sostituisce il manovratore, tutto dominato dai 485 metri del grattacielo pi alto del mondo, le torri gemelle Petronas.
 Scegliamo una strada alberata davanti alla residenza dell’ambasciatore inglese che dopo un paio di giorni viene persino a farci visita: una figura tipicamente britannica, dai tratti simpatici e alla mano.
Scegliamo una strada alberata davanti alla residenza dell’ambasciatore inglese che dopo un paio di giorni viene persino a farci visita: una figura tipicamente britannica, dai tratti simpatici e alla mano.
 Ci fermiamo alla Boh Tea Estate e facciamo lunghe passeggiate nella piantagione.
Ci fermiamo alla Boh Tea Estate e facciamo lunghe passeggiate nella piantagione.
 Dopo poche ore i bottegai ci riconoscono e ci sorridono, in giro si vede solo qualche raro turista e si respira un’atmosfera di grande serenità.
Dopo poche ore i bottegai ci riconoscono e ci sorridono, in giro si vede solo qualche raro turista e si respira un’atmosfera di grande serenità.
 Hat Yai è la prima città che incontriamo e sulla strada che conduce in centro gli edifici hanno facciate a specchio di vetro scuro che le fanno somigliare a sede di pompe funebri, ma le insegne discrete barber shop oppure massage parlour non lasciano dubbi: sono bordelli, a decine, uno a fianco all’altro.
Hat Yai è la prima città che incontriamo e sulla strada che conduce in centro gli edifici hanno facciate a specchio di vetro scuro che le fanno somigliare a sede di pompe funebri, ma le insegne discrete barber shop oppure massage parlour non lasciano dubbi: sono bordelli, a decine, uno a fianco all’altro.
 Hua Hin, che conoscemmo venti anni fa, era un modesto villaggio. Le barche erano ancorate lungo il molo di assi sconnessi; sulla spiaggia, davanti alle casette di legno dei pescatori, erano allineati i graticci con il pesce messo a seccare al sole. Tutto sparito: le capanne sono state ammodernate e ingrandite e ora sono diventate agenzie di viaggio, bar o ristorantini e per i pescherecci è stato costruito un porticciolo con moli in cemento armato oltre l’abitato.
Hua Hin, che conoscemmo venti anni fa, era un modesto villaggio. Le barche erano ancorate lungo il molo di assi sconnessi; sulla spiaggia, davanti alle casette di legno dei pescatori, erano allineati i graticci con il pesce messo a seccare al sole. Tutto sparito: le capanne sono state ammodernate e ingrandite e ora sono diventate agenzie di viaggio, bar o ristorantini e per i pescherecci è stato costruito un porticciolo con moli in cemento armato oltre l’abitato.
 Uno dei ricordi più belli che ancora conserviamo del primo viaggio in Thalandia è quello del mercato di Damnoen Saduak.
Uno dei ricordi più belli che ancora conserviamo del primo viaggio in Thalandia è quello del mercato di Damnoen Saduak.
 All’alba però è ancora tutto silenzioso e le scalinate che scendono ai canali sono deserte: ne domandiamo la ragione e ci rispondono che gli autobus da Bangkok non arriveranno prima delle dieci. Aspettiamo, ed effettivamente a quell’ora inizia ad arrivare una processione ininterrotta di torpedoni che scaricano comitive di ogni nazionalità.
All’alba però è ancora tutto silenzioso e le scalinate che scendono ai canali sono deserte: ne domandiamo la ragione e ci rispondono che gli autobus da Bangkok non arriveranno prima delle dieci. Aspettiamo, ed effettivamente a quell’ora inizia ad arrivare una processione ininterrotta di torpedoni che scaricano comitive di ogni nazionalità.





